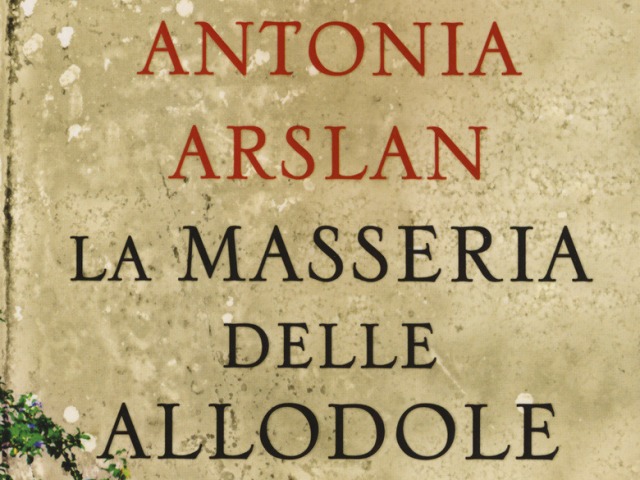
19-25 LUGLIO 2018
LXXII FESTA DEL TEATRO/FONDAZIONE ISTITUTO DRAMMA POPOLARE DI SAN MINIATO
LA MASSERIA DELLE ALLODOLE
Dal romanzo di Antonia Arslan
Regia Michele Sinisi
Con Stefano Braschi, Marco Cacciola, Gianni D’Addario, Giulia Eugeni, Marisa Grimaldo, Arsen Khachatryan, Ciro Masella, Stefania Medri, Giuditta Mingucci, Donato Paternoster, Roberta Rosignoli, Michele Sinisi, Adele Tirante
Drammaturgia Francesco M. Asselta, Michele Sinisi
Scenografia e luci Federico Biancalani
Aiuto regia Nicolò Valandro
Costumi Elisa Zammarchi
Co-Produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Arca Azzurra Teatro per Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato
Ci sono testi che si adattano particolarmente ad essere rappresentati in teatro per la potenza delle vicende narrate e la ricchezza di personaggi. Uno di questi è La masseria delle allodole, celebre romanzo finalista al Premio Campiello e al Premio Stresa di Narrativa del 2004 e diventato poi un film firmato dai fratelli Taviani. Il romanzo racconta uno degli eventi più drammatici del ‘900. Il genocidio degli Armeni da parte dei turchi durante la prima guerra mondiale, ritrova, nelle parole di Antonia Arslan, un frammento di questa vicenda, ricostruita dall’autrice sul filo dei ricordi familiari e consegnata alla memoria collettiva in un intreccio di storia e poesia, teso come un thriller e emozionante come una storia d’amore. Portando in scena questo testo nell’ambito del Festival di San Miniato, Michele Sinisi sfida la complessità dell’opera per raccontare la tragedia di un popolo “mite e fantasticante” e la struggente nostalgia per una terra e una felicità perdute. Raccogliendo la sfida etico-civile proposta dal Festival che tematizza il dialogo interreligioso come strumento di salvaguardia della pace, il regista sulla scena racconterà di come la politica, completamente svincolata dalla morale, appaia indifferente ai valori della civiltà e di come, in assenza di limiti umani, anche il genocidio diventi “utile a qualcosa”.
Lo spettacolo
Il nostro lavoro su La masseria delle allodole si focalizza su una continua azione scenica sviluppata in un pranzo armeno, realmente vissuto sulla scena, durante il quale si discute. Di cosa si discute? Di tutto quello che ci piace, di scienza, di poesia, di amore e sessualità di sacre scritture e di ornitologia, di matematica e di Dio, di musica e di contrasti generazionali. Cos’è questo discorrere, questo agire continuo anche nelle divergenze? È la vita, e per me è la bellezza. È quello che giudichiamo banale, inutile e noioso ma che alla fine dei giorni diventa fantastico. Quella normalità che nel ricordo acquista un valore superiore a qualsiasi potere terreno e presente: è la bellezza che rivela la sua potenza, diventando spaventosa, fastidiosa. Questo pranzo, questa convivialità in scena sono metafora di una condizione di fascinazione spirituale e carnale che esercita la storia della cultura armena, intrisa di fede e di vita allo stesso tempo, di grande emancipazione alimentata da un progresso culturale fortemente in contatto con la Memoria. A questo Eden fa da contraltare il dialogo politico tra chi vuole mettere in atto lo sterminio e chi invece, all’interno dell’esercito stesso, si oppone ad esso anteponendo al massacro la propria umanità. Questi due piani - il pranzo e il dialogo politico - sono montati in modo alternato. Sono al principio due binari paralleli che si intersecano gradualmente attraverso una storia d’amore: quella tra il soldato turco Djelal e l’armena Azniv. Questa relazione impossibile si fa archetipo di un tragico esempio shakesperariano: come tra montecchi e capuleti per dirla con le parole della Arslan. Il soldato prova in tutti i modi a salvare la bella armena dalla strage imminente; lui sa quello che al tavolo della politica turca si sta pianificando in quel lontano 1915: vogliono eliminare ogni intralcio al progetto della “grande Turchia” perché “gli armeni aprirebbero le porte all’avanzata russa in quanto infedeli (sono cristiani) e disinteressati a questo progetto politico”.
La strage alla Masseria
Nel luogo incantato dei ricordi di ciascun essere umano, nel posto caldo e protetto di ciascuno di noi, inizia la carneficina. Ogni maschio di quella famiglia è ucciso nel più macabro dei modi: Sempad è decapitato, I suoi figli maschi sgozzati nel momento in cui tentano di riappacificarsi col padre con cui poc’anzi avevano litigato, i neonati infilzati dalle baionette, Krikor è evirato; le donne sottoposte a torture fisiche, psicologiche.
Questa Guernica è rappresentata, in scena, da un gruppo in assetto antisommossa che distrugge nel senso materico del termine tutto ciò a cui si è assistito nella prima parte, la costruzione della vita è cancellata dalla bruttura del gesto, delle parole, dall’assenza di carezze e di baci, dal ribaltamento di una scena improvvisamente trasformata in un’asettica stanza di metallo zincato, priva di ogni sentimento. L’unica superstite sarà Shushanig (moglie di Sempad) che accompagnerà questa storia tentando disperatamente di salvare le figlie dalla strage. Azniv invece morirà per salvare la generazione che segue. L’eco di quelle danze, di quella poesia, di quel piacere della tavola, di quella sensualità e di quella spiritualità, si riaffaccerà sulla scena quando, verso la fine, gli autori della strage illudendosi di aver distrutto tutto troveranno per terra un piccolo richiamo meccanico per allodole, reperto di una lezione di ornitologia nella masseria. Lo spettacolo è un racconto che si sviluppa sulla scena attraverso un corpo narrativo corredato di parole, segni scenografici, suoni e azioni che contribuiscono in ugual misura a comunicare i fatti narrati: le parole scritte da Antonia Arslan sono qui tradotte in fatti di cui essere partecipi, esperienze umane di cui essere testimoni.
Note di regia
Nell’allestimento ho fondamentalmente seguito l’esperienza registrata nella prima lettura del romanzo della Arslan. La prima parte di quell’opera mi ha affezionato a quella famiglia, alla loro umanità, alla semplicità della vita, compresi i momenti di incomprensione e di litigio, così come le occasioni di gioia e speranza. La seconda parte mi è invece arrivata come un macigno sullo stomaco. A tratti ho avuto difficoltà nel proseguire la lettura del romanzo. Dal momento dell’irruzione dei turchi in masseria ho provato fastidio nel leggere le torture, le decapitazioni e l’evirazione dei maschi, la deportazione e gli stupri sulle donne, i maschietti appena nati infilzati dalle baionette. In quella seconda parte del romanzo si affaccia quanto di più brutale la nostra paura possa immaginare. Da quella prima lettura ho iniziato ad approfondire le questioni storiche e culturali del popolo armeno così come i segni di una narrazione non solo verbale. Con lo scenografo Federico Biancalani e con il drammaturgo Francesco Maria Asselta abbiamo riattraversato i fatti di quella storia cogliendo le parole e le argomentazioni che meglio potessero esprimere il piano politico di quelle decisioni, che portarono a compiere il primo genocidio della Storia. Gli argomenti sono diventati improvvisamente grandi e lunghissimi.
Ma quella prima impressione ha finito per mantenere una concretezza spietata. Continuamente è tornata alla mente l’irruzione in masseria e la violenza che ne seguiva. Un rito di passaggio tra la vita e la morte, un segno che tra parole, suoni e materia traducesse sulla scena un’esperienza analoga a quella prima lettura. Ho continuamente cercato questo. La famiglia arriva in quello spazio dell’anima, in masseria, per trascorrere gli ultimi interminabili attimi di una vita densa di piacere, di bellezza e di condivisione, di primi amori e di tratti scultorei, di poesia e di erotismo, di spiritualità e di canto. Questi personaggi si aggrappano a quanto di più semplice la vita possa donare ad ogni essere umano: la condivisione del respiro, fino all’ultimo. Shushanig prevede qualcosa, vede oltre il presente immagini di orrore che presagiscono il compimento di una strage nascosta tra le ultime parole del patriarca Hamparzum: fuggite, fuggite…
Sempad, come sempre tiene banco tra i sorrisi dell’intera compagnia mentre cerca di dialogare con suo figlio Suren; Veron sogna di andare a Boston da suo fratello Rupen; Azniv è incantata dal corteggiamento del soldato turco Djelal.
Qual è la consistenza di una tragedia come quella del genocidio armeno? La vastità del pensiero forse potrebbe sostenerne le dimensioni, ma l’intensità giusta credo sia data dall’assenza che ne consegue. Ogni momento di vita vissuta si trasforma in volti ed emozioni che non ci saranno più. Ogni occasione diventa perduta per sempre. La ferita che resta dopo una strage brucia in modo direttamente proporzionale all’amore generato da quella vita troncata. In scena, intorno al tavolo, abita nella prima parte uno spazio fisico ed emotivo, leggero come una nube e affascinante quanto Dio. Il gioco tra loro è di un’innocenza straziante quanto la carneficina prevista da Shushanig. A questo piano in masseria si alterna in parallelo un dialogo politico tra due personaggi che discutono sulle ragioni storiche di quel genocidio deciso a tavolino. L’unico ponte tra i due mondi è Nazim che tradisce il conoscente Sempad informando i turchi degli spostamenti della famiglia armena. Questi due piani dell’anima si incroceranno all’infinito, in quella dimensione ahimè umana per cui ciascun essere vivente finisce per cedere al male, che “esiste quando Dio non c’è”. Nella seconda parte, durante la strage, l’intero gruppo di attori giocherà tragicamente a far crollare tutto ciò che si sarà costruito in scena nella prima parte intorno al tavolo, durante quella vita bella nella masseria delle allodole. Senza parole, l’intera struttura della prima parte collasserà. Gli unici suoni umani saranno quelli che un’allodola in scena ricorderà dopo la strage, avvenuta sotto gli occhi di tutti. Come, del resto, avviene a noi tutti i giorni. Seduti sulle nostre poltrone.
Michele Sinisi
Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare
Tutte le notizie di San Miniato
<< Indietro








